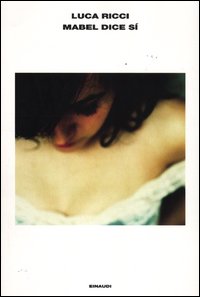Anna Karenina, la recensione
In Anna Karenina convivono più anime: il personaggio è in balìa dei suoi dèmoni, il film è un intreccio di forme d’arte che si sposano l’una con l’altra, senza tradirsi, in un’equilibrata fusione. Una sorta di game of mirrors che non lascia requie allo spettatore, tingendosi a tratti di fiabesco e surreale: il teatro s’insinua sottile fra le pieghe in movimento delle scene – e quelle sontuose degli abiti -, per incrinare le certezze del pubblico e provocarne l’attenzione sotto il profilo razionale; le inquadrature-quadro, vere e proprie tele incorniciate dal buio della sala, smentiscono la ragione e affogano chi guarda nel lirismo e in una resa incondizionata all’emozione; le coreografie delle scene d’insieme strizzano l’occhio al musical e danno il meglio di sé quando trasmettono, con la leggerezza tipica di quel genere, pagine di Storia firmate dalla collettività di un popolo.
Il merito di Joe Wright sta forse soprattutto nell’aver sfruttato il mezzo cinematografico al grado massimo della sua intensità: ecco perché l’impiego di riferimenti ad altre forme artistiche si rivela davvero un arricchimento e non una fuga. Il regista rispetta scrupolosamente la regola del “narrare per immagini” e sviluppa, portandolo fino al trionfo visivo, lo strumento del ballo, già utilizzato in nuce in Orgoglio e pregiudizio, mentre la Lizzie fanciulla e ribelle di allora ha lasciato il posto all’adulta e tormentata protagonista del romanzo di Tolstoij. La sequenza del valzer, che si dispiega generosamente nel tempo, è una magistrale armonizzazione di forma e contenuto: richiama alla memoria precedenti illustri come Il Gattopardo e ci racconta tutto senza dire niente, senza che sia pronunciata una sola parola. Il film inoltre scorre equidistante fra le due polarità che segnano la vicenda narrata: la sfera privata e la sfera pubblica, a rimarcare il cui confine interviene spesso l’elemento teatro nelle sue vesti scenografiche di palcoscenico e platea. Anna Karenina è un dramma privato che si consuma in pubblico e che nella sua ricaduta pubblica si fa tragedia:la passione folle porta Anna a dover rinunciare a tutto, ai figli, al prestigio, alla rispettabilità. Non a caso avvertiamo in maniera abbastanza forte sullo schermo lo stacco fra i protagonisti assoluti della vicenda (lui, lei, l’altro), i personaggi secondari, e la società che gravita attorno ritratta in una sorta di unicum indistinto quasi a creare una voce corale. E infatti della società aristocratica e ricca cui appartengono Anna e il consorte Karenin non ricordiamo i volti, ma un’immagine d’insieme: questo “personaggio” si realizza sulla scena in una molteplicità di esseri umani che all’unisono volgono lo sguardo verso Anna, colpevole di aver infranto le regole. Lo sguardo è un deliberato j’accuse verso una Keira Knightley superba allegoria del dolore e della dignità, assolta dal regista che sceglie di farla apparire luminosissima nel suo abito bianco. Ecco una delle inquadrature-quadro più preziose di questo film, in buona compagnia di altre come quella in cui di lì a poco prende forma l’abbraccio fra Anna e Aleksej, in una posa così pacata e composta da trasmettere, per dirla con Winckelmann, una sensazione neoclassica di “nobile semplicità e quieta grandezza”, in netto contrasto con il romantico divampare della passione che ha segnato la loro esistenza. E ancora oltre, la recitazione si tramuta quasi in scultura nella coreografia di una scena al plurale in cui gli attori sembrano statue nella loro completa immobilità, rendendosi metafora visiva della realtà storica e sociale dell’epoca, contraddistinta appunto da rigidità e immobilismo: tutto questo senza interrompere narrativamente il fluire della trama e senza distogliere l’attenzione dalla vicenda d’amore. Del teatro non mancano poi gli oggetti-simbolo, quasi veri e propri correlativi oggettivi: le falci dei contadini e i timbri degli uomini impiegati nella burocrazia sono simmetrici nella loro coralità e nella loro ritmica cadenzata, con cui riassumono un mondo poggiato sui pilastri dell’“agricoltura” e delle “scartoffie”. E poi c’è il gioco di bianco e di nero, e ci sono il trenino giocattolo che si trasforma in treno in viaggio a velocità inarrestabile, la galleria come tunnel rappresentazione di una drammatica strada senza ritorno, il bagliore delle scintille scoppiettanti dopo il baciamano che segna il turning point della vicenda e il fragore dell’incidente che investe un uomo interamente ricoperto di nero, sinistra prefigurazione di come si sarebbero svolti gli eventi, la veletta nera che si solleva ad indicare la fine del primo tempo della vita di Anna (non a caso «assassino» sarà l’appellativo rivolto all’innamorato)… e ancora i cubi del gioco di legno, («marionetta di legno» sarà la definizione data al marito), ricordo dei giochi innocenti di un’infanzia lontana e perduta, ombra del gioco spezzato dei suoi diciotto anni.
Mentre lo scorrere del Tempo, in questo film vellutato, sontuoso, potente, avvolgente nella sua spirale di realtà e immaginazione, nei suoi rapidi trapassi dall’oscurità più cupa alla luce più accecante, le ha insegnato, suo malgrado, con una battuta che riecheggia come un coup de théâtre, che per lei «non può esserci pace: solo miserie, o la felicità più grande».